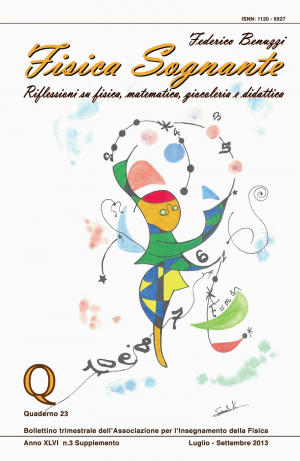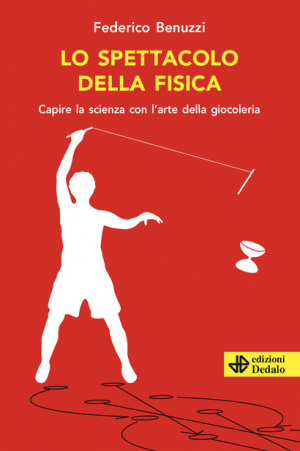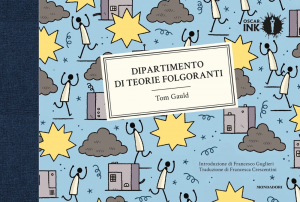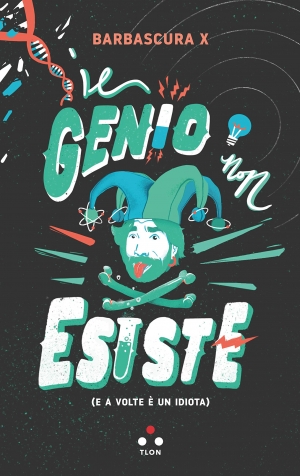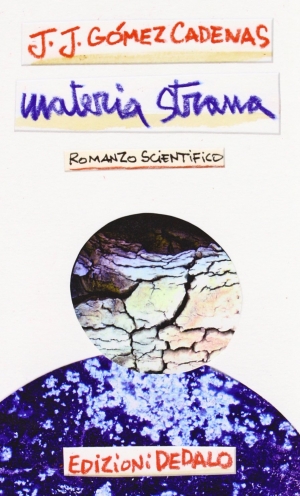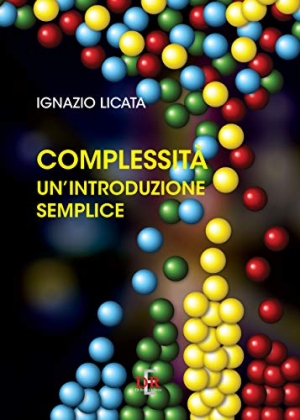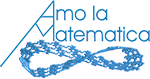Visualizza articoli per tag: fisica
Fisica sognante
«Fisica sognante» è stato pubblicato come bollettino trimestrale dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica a settembre 2013. Si tratta della seconda pubblicazione di Federico Benuzzi, dopo l’ebook «Giocolieri si diventa – manuale pratico di giocoleria», con Giochidimagia Editore. I due testi racchiudono le due anime dell’autore, che è insegnante e giocoliere, ma anche attore e presentatore: dotato di una personalità poliedrica, gestisce anche un blog, www.federicobenuzzi.com, e ha un canale YouTube che conta ormai più di duemila iscritti.
Il libretto è a metà tra il saggio scientifico e l’autobiografia, visto che numerose sono le riflessioni dell’autore sul proprio percorso e sull’insegnamento in particolare. È un saggio scientifico, perché tra le pagine possiamo trovare la spiegazione fisica del funzionamento del monociclo, del diablo o della giocoleria, ma l’inizio è dato dalle risposte alle domande che sono state poste allo stesso Benuzzi al termine degli spettacoli di giocoleria attraverso i quali divulga la fisica. Il ritmo narrativo è veloce e sembra di sentire la voce dell’autore che, come succede nei video pubblicati su YouTube, ci guida nella conoscenza dell’affascinante mondo della fisica. In alcuni punti è importante avere a portata di mano carta e penna, per poter seguire efficacemente i calcoli che vengono svolti. La parte di riflessioni, però, è forse il vero punto di forza del libro, soprattutto se, come nel mio caso, vi capiterà di leggere anche «Lo spettacolo della fisica», recente pubblicazione per la casa editrice Dedalo: si può entrare in contatto con il modo di essere di questo poliedrico insegnante di matematica e fisica e fare tesoro della sua esperienza per migliorare anche il proprio stare in classe. Federico Benuzzi è un insegnante che sa mettersi in discussione, ma che non è disposto a stravolgere il proprio modo di essere solo per ottenere più consensi, è un insegnante che sa usare le regole della scuola per creare un’alleanza con gli studenti, è un insegnante che riesce a spingere i suoi studenti a fare del proprio meglio, esattamente come ha chiesto al lettore, con questo libro, di vincere la propria paura della matematica per acquisire una maggiore consapevolezza delle cose.
Questo libro mi è stato regalato da una collega che aveva assistito ad uno spettacolo di Federico Benuzzi durante il Festival di BergamoScienza ed è rimasto a lungo nella mia libreria in attesa che lo prendessi in mano e gli dedicassi un po’ di tempo. Averlo letto dopo «Lo spettacolo della fisica» mi ha permesso di coglierne gli elementi di continuità e, al tempo stesso, le differenze che li rendono complementari.
Lo spettacolo della fisica
«Lo spettacolo della fisica», pubblicato a marzo 2021 dalla casa editrice Dedalo, è stato scritto da Federico Benuzzi. Nella presentazione del suo blog, www.federicobenuzzi.com, Benuzzi dice di essere «professore, conferenziere, presentatore, giocoliere, attore…»: è, in effetti, un personaggio poliedrico, che ha al suo attivo non solo spettacoli teatrali, ma anche libri, come «Fisica sognante», pubblicato come bollettino trimestrale dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, «La legge del perdente», pubblicato nel 2018 sempre per la casa editrice Dedalo, l’ebook «Giocolieri si diventa – manuale pratico di giocoleria», con Giochidimagia Editore ed è anche gestore del canale YouTube che porta il suo nome.
Esattamente come ne «La legge del perdente», il libro comincia con un incontro: ai compagni di avventura della scorsa volta, ovvero a Fazioli, l’ingegnere in pensione, e ad Andrea, studente universitario alla facoltà di statistica, si aggiunge Sara, cameriera aspirante attrice. Nella premessa, Federico Benuzzi ci dice che le pagine che andremo a leggere saranno «pagine di fisica, di didattica e di giocoleria» e in effetti c’è tutto quanto premesso e anche molto altro: oltre alla vicenda dei quattro amici, c’è una descrizione accurata di Bologna che fa veramente venir voglia di visitarla, ci sono la fisica e la matematica della giocoleria e, parlando di didattica, l’autore non si rivolge solo agli insegnanti, ma anche agli studenti. L’attività di Federico diventa, come succede sul palco, un’occasione per coinvolgere i suoi amici e per spiegare la fisica, che ritroviamo negli equilibrismi, spiegati con tanto di diagrammi delle forze, nelle leve e nella loro classificazione, nell’equilibrio, stabile instabile e indifferente e nel funzionamento del monociclo.
Oltre alla narrazione, ci sono le illustrazioni di Emanuela Bellisario e, distribuiti tra le pagine, troviamo dei QR code che rimandano a video e link, in coerenza con quanto scrive lo stesso autore: «è fondamentale, quando si spiega, mischiare insieme più registri comunicativi: è nella loro integrazione il massimo potere esplicativo possibile.»
Il libro è alla portata di tutti e si legge molto agevolmente: non è consigliato solo agli insegnanti, ma anche agli studenti delle scuole superiori, visto che i contenuti di fisica sono ben spiegati, mai banalizzati, ma chiari e semplici da capire. Mi ha colpito molto il fatto che Federico Benuzzi non abbia paura di stimolare il lettore a puntare un po’ più in alto e presenti quindi anche un percorso fatto di formule che possano aiutare a capire meglio la fisica. Non si tratta solo di spettacolo della fisica, perché anche la matematica ha un suo ruolo, protagonista negli schemi della giocoleria: non solo aiuta a rappresentare le combinazioni che si possono realizzare, ma può aiutare a trovare nuove combinazioni, come nel caso della “6x44x6”, «definito a furor di popolo il più bello schema di giocoleria che sia mai stato scoperto», per il quale «tutti riconoscono che, senza la matematica, probabilmente non lo si sarebbe mai trovato.»
Dopo aver visto dal vivo «L’azzardo del giocoliere», dal quale è tratto il libro «La legge del perdente», posso confermare che ciò che cogliamo in queste pagine è ciò che Benuzzi presenta nei suoi spettacoli, ovvero un intrattenimento intelligente, ma al tempo stesso coinvolgente, come mi hanno dimostrato i commenti entusiasti degli insegnanti di altre discipline, che mi hanno confermato la chiarezza degli argomenti spiegati. Consiglio vivamente la lettura di questo libro e, se possibile, la partecipazione a uno dei suoi spettacoli, perché, durante le sue performances dal vivo, la giocoleria e l’insegnamento, ovvero le due passioni, le due anime dell’autore, «potranno fondersi nuovamente insieme, in uno spettacolo unico, che vedrà andar di pari passo l’arte e la scienza. La tecnica e la sua descrizione matematica. Fisica e giocoleria.»
Dipartimento di teorie folgoranti
«Dipartimento di teorie folgoranti», edito da Mondadori nel 2020, è stato scritto da Tom Gauld, fumettista scozzese che collabora regolarmente con il Guardian, il New Yorker e il New Scientist. In particolare, questi fumetti sono apparsi originariamente proprio sul New Scientist.
Le vignette sono precedute da un’introduzione di Francesco Guglieri, editor di Einaudi, che collabora con il quotidiano “Domani” e con il mensile “Il” del Sole24ore e ha scritto articoli, racconti e reportage su vari giornali e riviste. L’introduzione, definita dallo stesso autore “folgorante”, è una storia a bivi (tipologia nata proprio nel mondo dei fumetti) che di fatto è come un viaggio tra le varie dimensioni della scienza. Guglieri ci racconta che, come Coleridge seguiva le lezioni di chimica della Royal Institution «per arricchire la sua riserva di metafore», Tom Gauld «con gli strumenti dell’ironia e della genialità grafica ha capito una cosa: che la scienza, con le sue scoperte, i mondi che ci dischiude… con i suoi giochi, anche… può essere uno straordinario deposito di bellezza». È proprio per questo motivo che «gli scienziati non sono secondi ai più visionari tra i poeti». E questa è l’impressione che si ha navigando fra queste 150 vignette che spaziano nel mondo scientifico, prendendo in giro alcune manie degli scienziati, ma mostrandoci anche i lati più nascosti della ricerca, protagonista in questo percorso. Gauld ci mostra cosa succede quando la ricerca va male, ma poi c’è spazio per la meccanica quantistica, il gatto di Schrödinger, il cane di Pavlov e la diffusione dei virus, c’è un generatore di titoli per libri divulgativi di successo, c’è spazio per la storia della scienza con Newton e Archimede, ad esempio, ci sono situazioni paradossali, c’è il confronto con la vita reale e la reinterpretazione della vita reale, ci sono gli appunti per lo scienziato pazzo in una conferenza stampa, ma c’è anche un vignetta nella quale vengono mostrati i vari stati della materia e che potrebbe essere usata con fini didattici… insomma c’è un po’ di tutto!
Leggendo questo libro mi sono ritrovata non solo a ridere spesso, ma anche a fotografare numerose pagine per poi inviarle ai miei contatti e per ognuno di loro e a seconda di quello che era il loro ruolo nell’ambito della ricerca scientifica, poteva esserci qualcosa di interessante all’interno di questo libro. Insomma, io già adoro i fumetti ma questo «Dipartimento di teorie folgoranti» offre uno spaccato della ricerca scientifica davvero entusiasmante e credo che non perderò occasione per utilizzare queste vignette nel presentare gli argomenti più complessi in classe. Grazie a Tom Gauld per questo momento di svago, ma al tempo stesso di approfondimento perché, come dice Guglieri nell’introduzione, «riesce a mettere in comunicazione la pancia con la testa».
Einstein forever
«Einstein forever» è stato pubblicato nel gennaio del 2020 dalla casa editrice Bollati Boringhieri. L’autrice, Gabriella Greison, è una scrittrice laureata in fisica e un’attrice che porta i suoi spettacoli in tutta Italia, approfittandone per divulgare le sue conoscenze in particolare sulla fisica moderna e sulle grandi donne che ne hanno permesso lo sviluppo.
È il secondo libro che Greison dedica a Einstein, dopo «Einstein e io», ma questo si riferisce alla seconda parte della vita del fisico, a quella ambientata in America, dal 1932-33 quando lascia la Germania fino al 1955, l’anno della sua morte. Non è un caso che l’autrice si dedichi ancora alla figura del fisico, perché «l’eredità che abbiamo ricevuto da Albert Einstein è immensa»: la sua è una «dichiarazione d’amore nei confronti di chi ci ha insegnato a sognare, e ci ha rivelato il segreto di come restare bambini per sempre». D’altra parte, il celebre fisico è una “icona pop”, cioè un vero e proprio modello, una figura di riferimento negli ambiti più diversi.
Gabriella Greison ha svolto come sempre un grande lavoro di ricerca: presso gli archivi della Hebrew University di Gerusalemme e a Princeton, dove ha avuto modo di incontrare spesso Freeman Dyson, fisico e matematico britannico, mancato subito dopo la pubblicazione del libro. È lei stessa a raccontarci di come Dyson l’abbia fatta «viaggiare con la mente» permettendole la stesura di questo libro.
Suddiviso in tredici capitoli, non numerati ma distinti l’uno dall’altro con un simbolo scientifico, ogni capitolo è una risposta ad una lettera che Einstein ha ricevuto, nel corso della sua vita, dai bambini oppure a lettere a noi contemporanee: Gabriella Greison si avventura in una risposta un po’ più impegnativa, mentre Einstein, pur rispondendo a tutte, si limitava ad alcune battute. In ogni capitolo c’è una seconda parte, intitolata Extra, nella quale la Greison racconta degli aneddoti legati alla passione per la musica di Einstein che si esibiva spesso con il suo violino, che aveva chiamato Lina e del quale aveva molta cura. Non è la prima volta che l’autrice collega la sua narrazione alla musica, in questo caso alla musica che Einstein amava.
Ci sono cinque capitoli dedicati alla fisica, con la spiegazione della celeberrima formula E=mc2, la descrizione dello spazio-tempo, la nascita della fisica quantistica, la gravità, gli ultimi studi che Einstein ha fatto a Princeton e, come in una previsione del futuro, i viaggi su Marte. Due capitoli sono dedicati a due amicizie importanti, ovvero Bohr e Gödel e poi c’è spazio per la descrizione della sua vita, l’atteggiamento di Einstein nei confronti delle minoranze, il percorso che ha fatto per diventare il fisico che tutti conosciamo, il suo anticonformismo e il suo rapporto con Dio.
Il libro è una lettura interessante per chiunque, anche per coloro che non hanno conoscenze scientifiche approfondite, visto che anche i capitoli dedicati alla fisica hanno un carattere divulgativo: non dimentichiamo che Gabriella Greison è abituata a spiegare la meccanica quantistica a chiunque, con monologhi teatrali. Proprio in considerazione della sua bravura come attrice, ho approfittato della possibilità di leggerlo, attraverso la sua voce, con Audible.
L'ordine del tempo
«L’ordine del tempo» è stato pubblicato nel 2017 da Adelphi. L’autore è Carlo Rovelli, fisico teorico e membro dell’Institut universitaire de France e dell’Académie internationale de philosophie des sciences, e la sua principale attività scientifica avviene nell’ambito della teoria della gravità quantistica a loop, della quale è uno dei fondatori. Per la sua opera di divulgazione, nel 2015 ha vinto il Premio Letterario Galileo per il libro «La realtà non è come ci appare»: il premio è stato istituito nel 2007 dal Comune di Padova, per incentivare la diffusione della cultura scientifica, soprattutto tra i giovani, e celebrare il prestigio dell’Università che ha visto Galileo Galilei tra i suoi docenti.
Fin dall’inizio, Rovelli ci racconta che il tempo è diverso «da questo uniforme scorrere universale» e «resta il mistero forse più grande». Le sue intenzioni sono chiare: «nelle pagine che seguono, racconto quello che abbiamo capito del tempo, le strade che stiamo seguendo per cercare di capire meglio, quello che ancora non capiamo e quello che mi sembra di intravedere».
Il libro è diviso in tre parti: nella prima viene riassunto il tempo spiegato dalla fisica moderna ed è un po’, come dice l’autore, «il racconto di questo sfaldarsi del tempo». Nella seconda parte, Rovelli descrive quello che resta una volta che si è tolta tutta la sovrastruttura della fisica e la terza, che è quella più difficile – come ci dice l’autore stesso – è comunque «la più viva e quella più vicina a noi». Anche di fronte alle difficoltà, l’autore cerca di incoraggiare il lettore a intraprendere il viaggio della lettura: «Qui il libro diventa magma rovente di idee, talvolta luminose, talvolta confuse; se mi seguite, vi porto fin dove io credo arrivi il nostro attuale sapere sul tempo, fino al grande oceano notturno e stellato di quello che ancora non sappiamo.»
La prima idea che abbiamo di tempo è di qualcosa che scorre allo stesso modo in tutto l’universo, ma già dai primi capitoli Rovelli ci fa notare come il tempo scorra «a velocità diverse a seconda di dove siamo e a che velocità ci muoviamo». Non c’è solo il problema della velocità, che in qualche modo ci è diventato quasi familiare sentendo parlare della teoria della relatività di Einstein: c’è anche il problema della differenza tra passato, presente e futuro, una distinzione che di fatto si perde se osserviamo le equazioni elementari che descrivono la realtà fisica. In questo viaggio che comincia, prevedibilmente, con la teoria della relatività, entrano in gioco anche l’entropia e quindi la termodinamica, ma arriviamo fino ai concetti abbastanza complessi della meccanica quantistica e Carlo Rovelli non ci fa mancare il suo sostegno, visto che, di volta in volta, accompagna la sua narrazione con immagini molto esplicative e, al tempo stesso, con piccoli riassunti, che nei punti più salienti fanno in qualche modo da raccordo e da chiarimento rispetto a quello che è stato il percorso effettuato. Potremmo dire che il suo stile è didattico, proprio come quello di un insegnante che ripete più volte gli stessi concetti, e non mancano gli esempi che ci aiutano ad orientarci in questi percorsi complessi, ma soprattutto lontani dall’immagine della realtà che abbiamo nella nostra mente. Nel testo, ci sono numerosi riferimenti alla cultura classica e potrebbe valere un esempio su tutti, quando la struttura temporale del mondo viene spiegata con un’analogia: «Chi appartiene alla “stessa generazione” di Leonida? Gorgo, che è la madre di suo figlio, o Cleomene, che è figlio dello stesso padre?». «La relazione di figliolanza stabilisce un ordine fra gli esseri umani, ma non fra tutti gli esseri umani», perché è una relazione di ordine parziale; allo stesso modo, non tutti gli eventi possono essere messi in ordine, come ci dimostra il diagramma di Minkowski. In altre parole, «Ogni evento ha il suo passato, il suo futuro, e una parte di universo né passata né futura, così come ogni essere umano ha antecedenti, discendenti, e altri che non sono né antecedenti né discendenti». È un esempio che mi ha molto colpito e che cercherò di tenere ben presente la prossima volta che mi ritroverò a spiegare il diagramma di Minkowski ai miei alunni.
Il viaggio, insomma, è piacevole anche se complesso, in un alternarsi di fisica e filosofia; il libro non è banale e meriterebbe una rilettura. Mi ha aiutato il fatto che mi sia fatta leggere questo libro proprio da Carlo Rovelli, attraverso Audible e, in questo modo, il percorso è stato più piacevole: certe sfumature che, probabilmente, con una lettura autonoma mi sarei persa, sono state evidenziate dal cambiamento di tono dell’autore, che dava enfasi e spessore ad alcuni passaggi.
Il genio non esiste (e a volte è un idiota)
«Il genio non esiste (e a volte è un idiota)» è stato pubblicato dalla Casa Editrice Tlon nel marzo del 2020. L’autore è Barbascura X, un nickname dietro il quale si nasconde non solo uno Youtuber molto famoso, ma anche un chimico, un musicista e un divulgatore scientifico particolarmente abile: parlano per lui i quasi 400 mila iscritti al suo canale.
Originario di Taranto, Barbascura ha fondato il suo canale nel 2014, cominciando con contenuti a sfondo satirico, a cui hanno fatto seguito i Riassuntazzi Brutti Brutti, video ironici nei quali racconta film e serie tv. Nello stesso stile, Barbascura ha cominciato a pubblicare i video di Scienza Brutta, documentari nei quali accanto alle informazioni scientifiche ci sono ironia e umorismo e nei quali si evidenzia la caratteristica fondamentale dell’autore, ovvero la sua capacità di demolire l’immagine di alcuni tra gli animali più amati, come il panda e il delfino. Nella vita reale, Barbascura X è un chimico e un ricercatore, che ha collaborato con diverse strutture di ricerca in tutta Europa.
Il libro «Il genio non esiste» è in realtà la trascrizione di un monologo teatrale che nel 2019 ha raggiunto le quaranta repliche. Contiene le biografie di sei scienziati famosi, Democrito, Newton, Darwin, Marconi, Tesla ed Einstein che vengono, in qualche modo, spogliati della loro aura di genialità per essere avvicinati al grande pubblico. Barbascura infatti sostiene che anche i più grandi scienziati, nel corso della loro vita, hanno commesso degli errori e «quello che chiamiamo “genio” è spesso semplicemente passione». I sei personaggi vengono descritti nelle caratteristiche che in qualche modo li possono avvicinare un po’ di più al lettore, perché il rischio è quello di ammirarli da lontano e, considerandoli inarrivabili, rinunciare ad imitarli. Mentre li descrive in modo dissacrante, Barbascura ci mostra come fondamentale per la ricerca scientifica non sia tanto il possesso di qualche particolare abilità intellettuale, ma soprattutto la capacità di appassionarsi e di studiare senza risparmiarsi. «La verità è che se ognuno di noi avesse investito la stessa quantità di tempo di quei “geni” nell’affinare la propria arte, commettendo gli stessi errori e nello stesso numero, scoprendo che qualche errore ci piaceva pure, provando, fallendo, mischiando, sperimentando, trovando il nostro personalissimo stile, forse oggi potremmo tranquillamente competere con loro ad armi pari.»
Barbascura scrive esattamente come parla, perciò leggere il suo libro è come sentirlo parlare nei suoi filmati su YouTube. La lettura è stata particolarmente interessante, forse anche perché condivido pienamente le idee di Barbascura e ritengo questo libro non solo estremamente godibile per chiunque, anche per chi non ha una preparazione scientifica, ma particolarmente interessante soprattutto per i ragazzi, che si affacciano alla vita e sono ancora impegnati nella scelta di un percorso. Non per niente, il linguaggio scelto è proprio quello che usano loro. Mi ha colpito in particolare quanto Barbascura scrive riguardo le donne: i sei protagonisti sono tutti uomini, ma l’autore non manca di sottolineare, quando gli è possibile, il ruolo delle donne nell’ambito della ricerca scientifica, evidenziando che «sono esattamente come gli uomini, né meglio né peggio».
Materia strana
«Materia strana» è il titolo di questo romanzo scientifico pubblicato dalle Edizioni Dedalo nella collana di narrativa scientifica ScienzaLetteratura, «pensata per chi ama leggere e vuole capire di cosa parliamo quando parliamo di scienza nel XXI secolo». È stato scritto da Gomez Cadenas, un fisico impegnato nella ricerca di particelle pesanti, e quindi particolarmente adatto per scrivere un’opera ambientata al CERN di Ginevra e in una centrale nucleare in Iran.
Il romanzo è ambientato in un’epoca imprecisata, nei primi anni 2000, in un arco temporale di sei mesi; l’inizio può essere un po’ disorientante, considerando i numerosi personaggi che vengono presentati nei primi capitoli. La protagonista femminile è Irene de Avila, fisica teorica, che è stata chiamata al CERN dalla sua direttrice, Helena Le Guin: qui si troverà a fare dei calcoli di probabilità, per prevedere la creazione di antimateria durante l’esperimento più importante che si svolge nel centro. Il suo incontro con Hector Espinoza, fisico e militare che sta svolgendo per l’ONU un lavoro della massima segretezza, è del tutto casuale, ma da quel momento le loro vite restano strettamente intrecciate e in questo intreccio trascinano con sé anche i personaggi che ruotano loro attorno. I momenti di contatto, però, sono anche più di quelli dati dalla loro frequentazione saltuaria e sporadica, visto che nel mezzo della sua missione in Iran Hector scoprirà poi un legame particolare con questa donna che non riesce a dimenticare. La vicenda è particolarmente coinvolgente e lascia il lettore in sospeso, invitandolo a non abbandonare la lettura.
Edito in Italia nel 2012, la sua prima pubblicazione risale al 2007 e proprio nel 2008 ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’LHC: da più parti si sentiva parlare dei rischi per la sopravvivenza dell’intera umanità sul pianeta, le cose quindi raccontate dall’autore non sono di pura invenzione, ma ricalcano in qualche modo quello che stava avvenendo, ovvero quello che avviene quando una ricerca scientifica di queste dimensioni diventa nota a tutti e quindi chiunque si permette un commento senza conoscere realmente i fatti.
La lettura è stata interessante, e mi sento di consigliarla non solo agli appassionati, ma anche a coloro che hanno sentito parlare soltanto vagamente del CERN. Questo genere di libri diventa un modo per muovere i primi passi in argomenti complessi come la fisica delle particelle, ma questo timido ingresso può diventare un’occasione per approfondire le proprie conoscenze. L’autore, al termine della vicenda, spende qualche pagina per spiegare con chiarezza quali siano gli argomenti scientifici trattati nel libro e per questo motivo è bene non interrompere la lettura una volta arrivati all’epilogo.
Complessità. Un'introduzione semplice
Ci sono libri che trovano il proprio spazio al momento giusto e riescono quindi a dare risposte e sistematicità a un percorso già in atto. È il caso di «Complessità. Un’introduzione semplice» di Ignazio Licata, pubblicato nel 2018 dalla Di Renzo Editore, casa editrice specializzata nella divulgazione scientifica. Nelle ultime settimane, la scienza ha rincorso le risposte a questa pandemia, mentre la matematica ha rappresentato i dati in diagrammi sempre più completi nel tentativo di una previsione non sempre possibile. E sono proprio questi gli aspetti indagati in questo libretto, nato dopo una serie di incontri con il pubblico, pubblicato già nel 2011 con la casa editrice :due punti. Per quanto Licata sia un fisico, non si parla solo di fisica, ma di tutti quei fenomeni complessi che hanno a che fare con la spiegazione del mondo in cui viviamo. L’idea di fondo è che il riduzionismo abbia portato con sé la convinzione che ogni fenomeno sia descrivibile attraverso un sistema di equazioni e prevedibile nel suo sviluppo futuro: la realtà, più complessa di quanto le equazioni sappiano dire, non è così facile alla previsione e non può avere, quindi, risposte semplici.
Il libro è un inno alla scienza, attraverso la descrizione del suo modo di agire e l’elenco dei suoi limiti, perché, come ci ricorda il teorema di Gödel, non è possibile ottenere una descrizione della realtà che sia, al tempo stesso, coerente con se stessa e completa, mentre il principio di indeterminazione di Heisenberg trova una nuova forma nel dirci che, di ogni argomento, se scegliamo la profondità rinunceremo alla visione generale e se preferiamo quest’ultima ci ritroveremo con una descrizione generale ma superficiale della realtà.
La lettura è consigliata agli insegnanti, responsabili di trasmettere un’idea di scienza che sia il più realistica e corretta possibile, ma anche agli alunni che, arrivati alla fine del proprio percorso superiore, sentano l’esigenza di capire meglio quali siano le risposte che è lecito chiedere alla scienza. La lettura è consigliata a tutti coloro che credono che sia possibile ottenere risposte semplici per problemi complessi: la descrizione della realtà è più difficile di quanto si immagini, come la realizzazione della mappa di una regione può facilmente dimostrare.
Nikola Tesla l'inventore del futuro
Tra le collane di EL, casa editrice specializzata in libri per ragazzi, spicca la collana “Grandissimi”, cui appartiene questo libretto. Sul sito della Casa Editrice questa è la descrizione della collana: “I grandi della Storia a portata di bambino. Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo proprio, con le proprie parole, le proprie invenzioni, le proprie scelte.” Da Giulio Cesare a Francesco d’Assisi, da Anne Frank fino a Einstein, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. La collana ha come età minima di lettura i sette anni.
«Questa è una storia da leggere a letto di sera, mentre fuori piove.» Così ha inizio la storia di Tesla, raccontata per i più piccoli da Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi.
La storia ha inizio la notte del 9 luglio 1935: Tesla è uno degli ospiti solitari del New Yorker Hotel e Jude O’Connor è il fattorino quindicenne che si lascia incuriosire da quest’uomo che, in prossimità della mezzanotte, si aggira per i corridoi dell’albergo. Nel salone delle feste, Tesla è atteso da una folla di giornalisti ai quali racconterà la propria storia e che festeggeranno insieme a lui il suo settantanovesimo anno. Preso dal racconto, Tesla si lascia sfuggire la verità su un principio di terremoto avvenuto a New York e che l’aveva visto tra i fautori, tanto che il giorno dopo i giornali titolano “Ecco come avrei potuto distruggere New York!”.
Esattamente un anno dopo, Jude si ritrova ancora ad accompagnare Tesla nel salone delle feste dell’albergo, ma nonostante lo scienziato parli con enfasi di un raggio della morte che metterebbe fine a ogni guerra, pochi sono disposti a dedicargli la propria attenzione.
Il racconto prosegue con l’attacco a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 e la richiesta di Tesla di convocare al più presto una conferenza stampa. Ma, a parte la visita di re Pietro II di Jugoslavia l’anno seguente, nessuno era più disposto ad ascoltare Tesla. L’ultimo giorno dell’anno del 1943, Jude ha l’occasione di parlare con l’eccentrico scienziato un’ultima volta, prima della sua morte. L’argomento è un’affermazione fatta da Tesla durante il loro primo incontro: Jude vuole una spiegazione. Ed è così che comincia un dialogo sul legame tra la scienza e il denaro, legame che Tesla non ha mai considerato. Al giovane facchino, Tesla lascia una sorta di testamento spirituale: «non valutare mai un’idea dalle sole implicazioni immediate. Un’idea è un seme, ha bisogno di tempo e cure per germogliare. Un’idea è un appuntamento nel futuro. E tu lascia che sia il futuro a stabilire la verità e a valutare ciascuno secondo il lavoro e le sue realizzazioni. Il presente appartiene a chi si accontenta delle risposte semplici e delle cose evidenti.»
Scienziate nel tempo
Pubblicato da Ledizioni, «Scienziate nel tempo» è arrivato alla sua terza edizione: la prima è del 1998, e raccoglie ora più di cento biografie*. Le autrici sono entrambe insegnanti: Sara Sesti è insegnante di matematica, mentre Liliana Moro di italiano e storia e, insieme, ci offrono un «itinerario lungo la storia della scienza e dell’istruzione femminile che mette in luce figure per troppo tempo ignorate o sottovalutate». Sara Sesti cura la pagina Facebook “Scienziate nel tempo di Sara Sesti” e fa parte dell’Associazione Donne e Scienza, mentre Liliana Moro ha pubblicato il libro Profumi di donne, ovvero una storia della chimica al femminile; entrambe sono webmaster del sito www.universitadelledonne.it e questo libro è il culmine di un progetto pluriennale sulle biografie delle donne di scienza, iniziato nel 1997 (e ancora in corso) presso il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi con la mostra “Scienziate d’Occidente. Due secoli di storia”.
Il testo è una raccolta di biografie, ma anche qualcosa di più. Le biografie occupano al massimo un paio di facciate per ogni scienziata, perché obiettivo principale delle autrici era «raccogliere dati sulle vicende di alcune donne, cercando di riconoscere linee di tendenza e di individuare interrogativi aperti». Le autrici stesse evidenziano gli elementi comuni alle scienziate presentate: «un frequente interesse verso il campo della divulgazione», pazienza, tenacia e una «straordinaria efficienza nella operatività pratica»; «spesso affiancate da una figura maschile molto importante», è poi entrata in azione un’«opera di cancellazione della memoria storica», facilitata magari dal fatto che queste donne spesso hanno pubblicato i propri risultati con pseudonimi maschili o insieme agli uomini che le sostenevano, basti pensare all’«aiutante invisibile» Maria Winkelmann-Kirch.
La raccolta presenta le biografie in ordine cronologico e suddivise per periodi: ogni periodo è introdotto da un saggio generale, e così vediamo la figura della donna nella preistoria, nell’antichità, quando finalmente abbiamo i primi nomi, nel Medioevo, tra il XVI e il XVII secolo, e poi c’è una parte per ogni secolo fino ad arrivare ad oggi. Le ultime due raccolte sono dedicate alle scienziate che hanno partecipato a progetti collettivi e alle protagoniste della rivoluzione informatica. Si può scegliere una lettura in ordine cronologico oppure diversa, magari raggruppando le scienziate per disciplina (le discipline sono specificate già nell’indice), oppure facendo riferimento ai premi Nobel. Nella nuova edizione c’è una parte dedicata all’informatica, «per incoraggiare le giovani a una maggiore partecipazione alle discipline STEM», anche se di fatto ogni biografia è un’offerta di modelli positivi di figure femminili alle ragazze di oggi, permettendo «a una giovane di immaginare con maggiore naturalezza e disinvoltura una propria presenza nel mondo della scienza e della tecnica».
Il fatto che a ogni biografia sia dedicato un paio di pagine rende la lettura scorrevole e veloce: i capitoletti volano, da una scienziata all’altra, ma lo spazio dedicato ad ognuna è sufficiente per offrire uno spunto di riflessione, per fornire qualcosa di diverso e nuovo da dire in classe, mentre il quaderno degli appunti si riempie di numeri di pagine e di rimandi a questo o a quell’argomento trattato con la didattica. D’altra parte, io condivido appieno quanto le stesse autrici dichiarano nella presentazione: «una disciplina, vista attraverso la concretezza e la profondità delle biografie di coloro che ad essa si sono dedicate, assume connotazioni nuove, più vicine alla sensibilità degli adolescenti, poco incline all’astrazione e molto curiosa di esperienze complessive e di scelte morali».
*Dal 2018 gli aggiornamenti del libro sono a cura di Sara Sesti