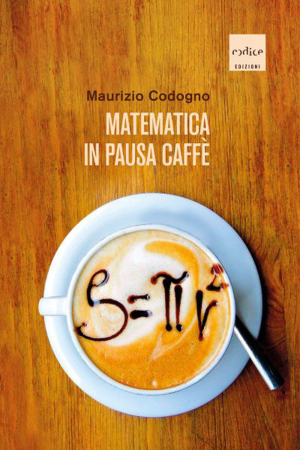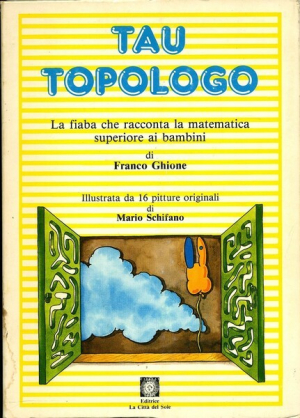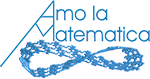Visualizza articoli per tag: matematica
Matematica in pausa caffè
«Matematica in pausa caffè» è stato pubblicato dalla Codice Edizioni nel 2014 (comparso in una nuova edizione nel 2020) ed è il terzo libro di Maurizio Codogno, che si definisce, dalle pagine del Post, un «matematto divagatore». Maurizio ha scritto numerosi libri, «per raccontare le cose che a scuola non vi vogliono dire, perché altrimenti potreste apprezzare la matematica»: «Matematica in relax» (2011), «Matematica e infinito» (2013), «Fantamatematica» (2014), «Alfabeto matematico» (2015), «Matematica in pausa pranzo» (2016), «Scimmie digitali» (con Paolo Artuso nel 2018), «Numeralia» (2019), «Chiamatemi pi greco» (2022). Gli interessi di Maurizio Codogno sono molti e variegati, considerando che bazzica la rete dal 1984, è laureato in matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa e in informatica, è portavoce di Wikimedia Italia, lavora alla Telecom, e gestisce il blog xmau.com, dove si definisce un «tipo semplice», come si può intuire dalla grafica del sito, principalmente testuale.
«Matematica in pausa caffè» offre una serie di spunti che possono essere usati per chiacchierare di temi matematici curiosi, nel tempo necessario per bere una tazza di caffè, visto che ogni argomento è trattato in tre pagine (in media). Gli ambiti trattati sono cinque e per ogni ambito ci sono sette pause caffè. L’obiettivo dell’autore è quello di stuzzicare la curiosità del lettore, facendolo divertire e portandolo a comprendere in modo intuitivo le idee portanti, aiutandolo a «farsi un’idea della struttura logico-matematica di quello che ci circonda». D’altra parte, senza la matematica saremmo facili vittime delle bufale, come dimostra l’analfabetismo numerico dilagante. Gli argomenti sono trattati in modo da essere comprensibili anche ai non matematici, e mostrano come si possano «comprendere le idee matematiche anche senza mettersi a fare chissà quali calcoli».
Il primo ambito esplorato è quello dell’aritmetica, con la spiegazione del prodotto tra i numeri negativi, la differenza tra media, moda e mediana, la prova del nove che rimanda all’aritmetica modulare, la classificazione dei numeri – tra i quali individuiamo quelli «di dubbia fama», come gli irrazionali e i surreali – il paradosso di Zenone che ci porta alla distanza di Planck, i logaritmi e la crescita esponenziale.
Il secondo ambito riguarda i paradossi, la probabilità e le previsioni: Codogno parla della probabilità bayesiana partendo da un semplice esempio, ci racconta il paradosso delle due buste, il gioco di Penney legato al lancio di una moneta, il paradosso di Simpson e la legge di Benford, propone un problema di Fermi attuale domandandosi quanto peserebbe la stampa di tutta Wikipedia in lingua italiana e affronta la matematica delle coalizioni, citando il Nobel per l’economia Kenneth Arrow e ragionando sui modelli matematici, che, in quanto modelli, «considerano solo alcuni aspetti della realtà» e sono certamente «utili per avere un’idea, ma non necessariamente attinenti alla realtà».
Il terzo ambito è quello dei giochi, intesi come giochi d’azzardo ma non solo, con la probabilità che aiuta il ragionamento e risolve apparenti paradossi. Mentre Codogno ci ricorda che il banco vince sempre, ci suggerisce come “vincere” alla roulette (appunto: ma vincere quanto?) e dispensa consigli preziosi: «Non lasciatevi prendere dal panico di fronte a un problema, e iniziate a cercare una scorciatoia per giungere alla soluzione!». Ritroviamo la matematica anche nel tennis, dove a volte vince il peggiore, giochiamo con le carte e con i dadi, e scopriamo le dismutazioni che ci offrono un calcolo che assomiglia solo graficamente al fattoriale. In tutto questo, «la matematica è un utile ausilio, ma il mondo reale non è sempre così matematico… checché ne dicesse Galileo.»
Eppure la quarta parte, Andando in giro, sembra dirci che la matematica si nasconde ovunque: quella che viviamo è una realtà pervasa di contraddizioni, perché scopriamo che un tratto di tangenziale in più potrebbe peggiorare il traffico, che è sempre la corsia del supermercato che non scegliamo quella che ci avrebbe portato più velocemente alle casse, che i nostri amici hanno più amici di noi, che gli ascensori vanno sempre in senso inverso rispetto a quello che servirebbe a noi, che gli autobus hanno sempre lunghi tempi d’attesa e forse sarebbe meglio perderli, che il traffico si comporta come un’onda e che la «marcia dell’ubriaco» potrebbe portarci alla legge dei grandi numeri e nasconde in sé un pizzico di pi greco.
L’ultimo ambito di indagine non poteva che essere quello informatico: Codogno ci racconta il metodo di John Horton Conway che dal «giorno del giudizio» ci porta al calendario, ci insegna che per piegare un A4 in tre parti sono utili i triangoli simili, ci invita a diffidare dei file troppo compressi, ci dimostra che una crittografia perfettamente sicura è praticamente inutilizzabile, confronta i CD e i vinili, ci parla della nuova vita della steganografia, mettendoci in guardia dai gattini che frequentano la rete, e non può che concludere il cammino con i Big Data.
Il percorso che ci viene offerto da Maurizio Codogno mostra la sua originalità anche nel capitoletto finale, la bibliografia/sitografia che ci offre spunti «per saperne di più»: gli approfondimenti sono linkati attraverso un link TinyUrl, uno dei tool storici per i blogger, che ci dà un’idea dell’esperienza dell’autore (un po’ come coloro che usano l’acronimo LOL al posto della più nota emoji).
«Matematica in pausa caffè» ci offre una passeggiata attraverso vari ambiti della matematica, non sempre così noti: è un po’ come se la realtà si aprisse davanti a noi come la pagina di un sito e Maurizio Codogno ci offrisse un accesso al linguaggio di programmazione nascosto, permettendoci di apprezzare ancora di più la realtà che ci circonda. Il libro è davvero alla portata di tutti: si può leggere nell’ordine proposto dall’autore, per cogliere meglio i rimandi tra i singoli capitoli, oppure si può scegliere anche un ordine personale, visto che ogni capitolo è indipendente dagli altri.
Il libro è un vero regalo per gli insegnanti di matematica, che condividono la volontà dell’autore di far apprezzare la matematica ai propri alunni (e di alleggerire un po’ il percorso scolastico, a volte tedioso, scandito da equazioni e disequazioni).
4 febbraio 2023
Verifica di matematica, classe prima liceo scientifico.
Argomento: recupero primo quadrimestre
Durata: 60 minuti.
1° febbraio 2023
Verifica di matematica, classe seconda liceo scientifico.
Argomento: algebra con coefficienti irrazionali e operazioni con i radicali
Durata: 120 minuti.
1° febbraio 2023
Verifica di matematica, classe prima liceo scientifico.
Argomento: scomposizione di polinomi
Durata: 30 minuti.
18 gennaio 2023
Verifica di matematica, classe prima liceo scientifico.
Argomento: scomposizioni di polinomi (raccoglimento totale, raccoglimento parziale, differenza di quadrati).
Durata: 20 minuti.
Tau topologo
«Tau topologo, la fiaba che racconta la matematica superiore ai bambini» è stato pubblicato nel 1985 dalla casa editrice La città del sole e purtroppo non è più in commercio, anche se è ancora disponibile online. L’autore è Franco Ghione, che è stato professore ordinario di geometria presso il Dipartimento di matematica dell’Università di Roma Tor Vergata e che è tuttora attivo nell’ambito della divulgazione, visto che ha coordinato il progetto Fibonacci, il lavoro collettivo che ha reso accessibile il Liber Abaci.
Nel libro compaiono anche sedici pitture di Mario Schifano, realizzate per illustrare la fiaba: il pittore e regista, scomparso nel 1998, è stato un punto di riferimento della Pop Art italiana ed europea e, per usare le parole dell’autore, «è riuscito a dare un’immagine concreta a questa idea».
Nell’introduzione, Franco Ghione ci informa che il libro è stato scritto per la figlia Valentina, quando aveva cinque anni ed è anche il racconto di alcuni incontri di matematica “astratta” per bambini, realizzati nel 1983. Il secondo capitolo del libro è stato scritto da Cecilia, figlia minore dell’autore, ed è quello che, nella finzione letteraria, dovrebbe essere stato scritto da Tau quando era piccolo, tanto che ha una grafia da scuola elementare.
Il libro ha inizio con la storia del signor Tau, che è interessato alle proprietà più semplici delle figure nello spazio, perché non ha «nessuna simpatia per gli angoli, le linee spezzate che con tutta tranquillità preferisce immaginare lisce». Per indagare le proprietà, utilizza rudimentali telai di legno, rendendosi conto che la linea retta diventa equivalente a una linea curva, mentre studia le nuvole e parla con una rondine. Si parla di figure connesse, di linee aperte e chiuse, fino ad arrivare al teorema di Jordan. Il secondo capitolo è quello più formale, con gli enunciati e le dimostrazioni di cinque teoremi, preceduti dalle indicazioni per realizzare praticamente la trasformazione continua delle figure, attraverso un foglio di gomma.
Negli ultimi due capitoli, ritroviamo un signor Tau, adulto, che fa giocare i bambini con la matematica: si comincia con il gioco dell’isola, durante il quale si introducono i concetti di omeomorfismo e di trasversalità, fino ad arrivare alla rappresentazione della curva di Peano. Nell’ultimo capitolo, si parla di tori e conigli, con l’enunciato del teorema di Jordan, mentre i bambini provano a verificare anche tridimensionalmente le proprietà indagate nel piano.
Il libro si è rivelato un ottimo testo per apprendere con leggerezza concetti matematici poco noti: consente un approccio pratico, visto che fornisce indicazioni utili per tutti coloro che avessero voglia di esplorare una matematica un po’ fuori dagli schemi.
«Tau ridacchiava contento, così convinto com’era che la matematica, la creazione matematica, trovava alimento soprattutto nel dubbio, nella critica.»
20 dicembre 2022
Verifica di matematica, classe prima liceo scientifico.
Argomento: calcolo letterale, prodotti notevoli, divisioni tra polinomi.
Durata: 90 minuti.
17 dicembre 2022
Verifica di matematica, classe seconda liceo scientifico.
Argomento: operazioni con i radicali numerici e letterali, condizioni di esistenza.
Durata: 120 minuti.
30 novembre 2022
Verifica di matematica, classe seconda liceo scientifico.
Argomento: semplificazione di radicali.
Durata: 15 minuti.
23 novembre 2022
Verifica di matematica, classe seconda liceo scientifico.
Argomento: condizioni di esistenza dei radicali.
Durata: 20 minuti.
© 2020 Amolamatematica di Daniela Molinari - Concept & Design AVX Srl
Note Legali e Informativa sulla privacy