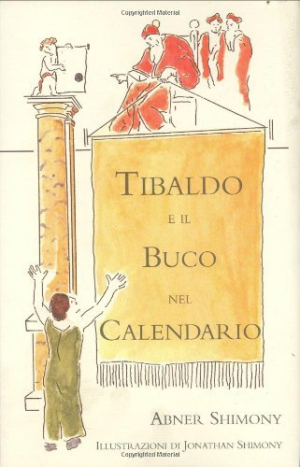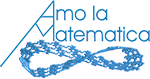Visualizza articoli per tag: romanzo
L'ultima risposta di Einstein
La vendetta di Pitagora
La donna che amava i numeri
Tibaldo e il buco nel calendario
L'energia del vuoto
Il mistero del Più
Gli artisti dei numeri
Le ostinazioni di un matematico
TRAMA:
Questa è la storia di un matematico, Armand Duplessis, che aveva davanti a sé un brillante futuro, ma che ha scelto di impegnare la propria vita nel tentativo di dimostrare la congettura di Goldbach. I singoli capitoli sono quasi separati, visto che il protagonista muore ben tre volte e ce lo spiega l’autore nell’introduzione: La morte del protagonista in un capitolo non incide, né deve farlo in alcun modo, sul suo comportamento nel capitolo seguente. Lo si ritrova vispo come una funzione che, superato qualche valore non ammesso, risuscita in un batter d’occhio: affondata verso – ∞ un istante fa, ora si avvicina a + ∞, pronta a nuovi asintoti.
Nato il 16 aprile 1964, ovvero 16.4.64, che potrebbe anche essere letto come 16 x 4 = 64 o come 24.22.26, Armand Duplessis sente che le potenze di 2 hanno in qualche modo segnato la sua vita. A sedici (=24) anni, seguì la serie televisiva Gli enigmi che sfidano l’umanità, durante la quale venne presentata la congettura di Goldbach: ogni numero pari è la somma di due numeri primi. Quella stessa sera, a tavola, annunciò la sua decisione. Sarebbe diventato un matematico. Non un professore di matematica, intendiamoci: un matematico. Perché aveva intenzione di essere il primo a dimostrare la congettura di Goldbach.
Scegliendo di dedicarsi alla teoria dei numeri, venne assunto dall’università di Lione: agli inizi, Armand era uno di quei pochissimi ricercatori che si mostrano all’altezza delle grandi speranze riposte in loro. In moltissimi ambiti della teoria dei numeri i suoi risultati furono stupefacenti, le sue intuizioni decisive, le sue pubblicazioni numerose, le sue idee fondamentali. Ma a 32 (=25) anni, Armand decise di dichiarare che avrebbe proseguito le sue ricerche nel tentativo di dimostrare la congettura di Goldbach.
Dopo essersi dedicato instancabilmente, in ogni momento della giornata, alla congettura, un giorno Armand decise di dimenticarsene, di liberare la propria mente, nel tentativo di pensarci meglio. Esattamente come fece Poincaré che, dopo essersi concentrato molto tempo e inutilmente su un problema, decise di partire per una gita e, mettendo piede sull’omnibus di Coutances, riuscì a trovare la soluzione. Armand sperava di trovare nell’accensione del proprio computer ciò che Poincaré aveva trovato salendo sull’omnibus. Ma non successe nemmeno questo… ha luogo semplicemente la sua seconda morte, mentre si smaterializza osservando la propria immagine.
Dopo la sua morte, i colleghi si trovano a farne un “elogio funebre” un po’ particolare, visto che commentano anche cinicamente la scelta di Armand di dedicare tutta la propria vita a una congettura così difficile: «Avrebbe potuto fare della grande matematica. Forse avrebbe potuto farne, voglio dire. Forse. Non lo sapremo mai, adesso. Ma se c’è una cosa certa, è che si è ostinato stupidamente».
COMMENTO:
Non bisogna cominciare la lettura di questo libro aspettandosi un romanzo normale, con un inizio e una fine. È un romanzo dai molti inizi e dalle tante fini – come dimostrano le tre morti del protagonista – un romanzo fatto in realtà da tanti singoli racconti un po’ fantastici, che descrivono però molto bene la vita di un matematico.
Non mancano numerosi agganci con la realtà matematica: i colleghi di Armand hanno, ad esempio, nomi che imitano quelli dei celebri matematici e cioè Potagore (Pitagora), Pacaré (Poincaré), Barbacchi (Bourbaki), Couchy (Cauchy), Bèrel (Borél), Lebogue (Lebesgue). Simpatica inoltre è la descrizione della presunta scoperta, da parte della moglie di Armand, dell’amante del matematico, secondo una deduzione fatta dopo aver rilevato l’improbabile ricorrenza dei multipli di 99.
Il testo è scorrevole e divertente e, verso la fine, l’autore ci parla anche di Goldbach e della comparsa della famosa congettura durante uno scambio epistolare con Eulero, avvenuto il 7 giugno 1742, ovvero 7.6.42… come nel caso della data di nascita del protagonista: 7 x 6 = 42.
La formula segreta
TRAMA:
Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio del 1512, durante il sacco di Brescia ad opera dei soldati francesi, Niccolò Tartaglia cercò riparo dentro il Duomo, ma i francesi assalirono i rifugiati e uno di essi gli inferse cinque ferite in volto. Niccolò guarì nel giro di qualche mese, grazie alle cure della madre, ma le ferite alla bocca gli causarono la balbuzie: i coetanei lo prendevano in giro per questo suo difetto chiamandolo “tartaglia” ed egli adottò questo nomignolo come cognome.
Nato a Brescia presumibilmente nel 1499 da una famiglia molto povera, Niccolò Tartaglia lavorò autonomamente alla propria formazione scientifica, studiando le opere di Euclide, Archimede e Apollonio. Tra il 1516 e il 1518 si trasferì a Verona, dove rimase fino al 1534; qui acquisì notorietà e rispetto, con il ruolo di maestro d’abaco. La fama raggiunta da Tartaglia è testimoniata dai quesiti da lui posti a numerosi interlocutori. A quei tempierano di gran voga in Italia le disfide tra matematici, di rango universitario e non: veri e propri duelli scientifici il cui svolgimento ricalcava i canoni dei tornei cavallereschi. Uno studioso inviava a un secondo alcuni problemi, che rappresentavano il guanto di sfida di queste particolari tenzoni, e lo sfidato doveva cercare di risolverli entro un termine prestabilito, proponendo a sua volta all’avversario ulteriori quesiti. La consuetudine voleva poi che ogni duello dall’esito contrastato culminasse in un pubblico dibattito, nel corso del quale i contendenti erano tenuti a discutere dei problemi scambiati e delle relative soluzioni alla presenza di giudici, notai, governanti e di una platea di spettatori sovente assai folta. Non era infrequente, inoltre, che tali disfide si facessero parecchio incandescenti, sconfinando dal piano scientifico a quello dell’invettiva personale. D’altra parte, la posta in palio poteva essere molto alta: il vincitore di una pubblica disfida matematica, ossia colui che aveva risolto il maggior numero di problemi, non guadagnava solo gloria e prestigio, bensì più concretamente anche un eventuale premio in denaro, nuovi discepoli paganti, l’acquisizione o la conferma di una cattedra, aumenti di stipendio e spesso incarichi professionali ben remunerati. La carriera dello sconfitto, invece, rischiava di rimanere seriamente compromessa.
Il secondo protagonista di questa storia è Gerolamo Cardano: nato a Pavia il 24 settembre 1501, si laureò in medicina nel 1526, ma solo nell’estate del 1539 fu accolto dal Collegio dei medici di Milano, che aveva osteggiato la sua elezione a causa dei suoi illegittimi natali. Divenne in seguito il medico più famoso e richiesto della città. Informato da un matematico che Tartaglia aveva trovato la formula risolutiva delle equazioni di terzo grado, si mise in contatto con lui all’inizio del 1539 per avere la formula, ma Tartaglia rispose negativamente alla richiesta: “quando vorrò pubblicar tal mia inventione la vorrò publicar in opere mie et non in opere de altri”. Dopo una corrispondenza dai toni abbastanza vivaci, Tartaglia si recò a Milano da Cardano in primavera: ebbero a disposizione diverso tempo per discorrere tra loro e confrontarsi su vari temi, uno dei quali non poteva che essere la questione delle equazioni cubiche e delle loro regole risolutive. Cardano giurò a Tartaglia che non avrebbe mai svelato la formula risolutiva e questi si lasciò convincere a rivelarla. I due smisero di scriversi nel gennaio del 1540 e non sono documentati ulteriori contatti personali o epistolari.
Mentre Tartaglia rivelava la formula, Cardano era in compagnia di un giovanissimo allievo, Ludovico Ferrari. Nato a Bologna il 2 febbraio 1522, Ferrari discendeva da una famiglia milanese: rimasto presto orfano, fu mandato a Milano come servitore nell’abitazione di Cardano, il quale, accortosi della sua predisposizione agli studi, si prese cura della sua istruzione. Nel 1542 si recarono a Bologna per far visita a un matematico: questi mostrò loro un vecchio taccuino appartenuto al suocero, Scipione Dal Ferro, nel quale i due trovarono la formula risolutiva delle equazioni cubiche. Dopo aver appreso la formula, Cardano e Ferrari si persuasero della necessità di diffondere in tutto il mondo scientifico le nuove conoscenze acquisite e Cardano, in particolare, si sentì svincolato dal giuramento fatto a Tartaglia. Nel 1545, Cardano pubblicò il volume Artis magnae, sive de regulis algebraicis più noto come Ars Magna, un testo destinato a imprimere una svolta profonda nella storia dell’algebra, determinando l’avvio di una nuova era per le ricerche matematiche. Nel suo trattato, Cardano attribuì agli autori delle formule risolutive i dovuti meriti e riconobbe i contributi di Ferrari, con il quale aveva collaborato. La formula risolutiva delle equazioni cubiche è spesso denominata «formula cardanica» poiché, pur non essendone stato lo scopritore, fu Cardano a farla conoscere al mondo scientifico, e per di più completa di dimostrazione.
Nel 1546, Tartaglia pubblicò Quesiti et inventioni diverse, nel quale si scagliò contro Cardano, che non aveva tenuto fede al giuramento di silenzio. Cardano non replicò all’attacco, ma lo fece Ferrari: il 10 febbraio 1547, inviò a Tartaglia un pubblico «cartello di matematica disfida», proponendogli di misurarsi con lui in un pubblico “duello”. I due continuarono a scambiarsi cartelli dal giugno all’ottobre del 1547 e si scontrarono il 10 agosto 1548 a Milano. Tartaglia abbandonò la disputa dopo il primo giorno, perché la riteneva invalidata dal comportamento del pubblico presente, apertamente schierato a favore dell’avversario, ma dichiarò di esserne il vincitore, contestando alcune delle risposte di Ferrari. Non possiamo sapere come siano andate davvero le cose, ma la maggior parte delle fonti riconosce in Ferrari il vincitore dello scontro.
Tartaglia morì a Venezia il 13 dicembre 1557, in solitudine e povertà. Ferrari morì a soli quarantatre anni, probabilmente avvelenato dalla sorella. Cardano morì il 20 settembre 1576, dopo aver visto giustiziare uno dei suoi figli per uxoricidio ed essere stato condannato dall’Inquisizione.
COMMENTO:
Quanto è raccontato in questo libro costituisceun complesso di vicende tanto sorprendenti e appassionanti da richiamare, crediamo, la curiosità anche dei non addetti ai lavori: vicende ricche di situazioni dal sapore romanzesco – intrighi, segreti, arroventate dispute erudite – e animate da personaggi affascinanti, geniali e bizzarri, capaci di eccellere nella loro epoca sia per virtù di intelletto che per umane debolezze. Con queste parole nell’introduzione, l’autore ci fornisce un ottimo motivo per leggere questo libro. Per molte persone, è difficile immaginare che tante passioni possano animare la scoperta di una formula matematica: per questo tutti coloro che considerano la matematica arida e priva di passionalità dovrebbero leggere questa storia.
Le ultime righe del libro:
Nella prima metà del Cinquecento, di fatto, Scipione Dal Ferro, Niccolò Tartaglia, Gerolamo Cardano e Ludovico Ferrari furono i quattro scintillanti moschettieri che illuminarono il cielo dell’algebra con le loro straordinarie e feconde scoperte. Scoperte originate non solo da genio creativo e abilità tecnica, ma altresì da passione, dedizione, perseveranza, competizione, gelosia, ambizione, stima, risentimento, impeto, sofferenza. Insomma, da tutto il carico di umanità che si può nascondere anche dietro una formula matematica.
Ipazia e la notte
TRAMA:
Ipazia è una filosofa, matematica e astronoma che insegna al Museo di Alessandria d’Egitto alla fine del IV sec. d.C. Fra le sue imprese c’è il commento a un libro del grande Tolomeo – al sistema geocentrico da lui proposto, Ipazia preferisce il sistema eliocentrico di Aristarco – e alle Coniche di Apollonio di Perga.
Un anno dopo la morte del padre Teone, Ipazia si ritrova a far lezione in un’Alessandria perennemente in tumulto: da quando l’imperatore Teodosio ha proclamato il cristianesimo religione di stato, il patriarca di Alessandria, Cirillo, durante le sue prediche istiga i cristiani alla violenza contro i pagani. Nel frattempo, anche la partenza per Atene di Sinesio, l’allievo preferito di Ipazia, contribuisce a farla sentire amareggiata e offesa per una separazione che sente come un tradimento. A questi si aggiunga il matrimonio di Sinesio con Fulvia: Ipazia ha sempre pensato che avrebbero condiviso la scelta della verginità e che sarebbero invecchiati insieme e, sull’onda dell’emozione, decide di sposare Evandro, un celebre grammatico, amico del padre. Dopo il matrimonio, però, non si concede al marito e questi, a un mese dalle nozze, la lascia.
La Chiesa entra sempre più prepotentemente nelle questioni di stato e Teodosio ordina che vengano requisiti tutti i templi pagani per farne delle chiese cristiane: ad Alessandria si arriva ad una vera e propria carneficina. Ipazia, che si lascia guidare dalla ragione della filosofia, cerca di scoraggiare la violenza: «Se vogliamo pensare e agire secondo virtù, dobbiamo volere un mondo in cui a ognuno sia permesso di onorare i suoi dei, quali che siano, e di praticare pubblicamente il suo culto, senza che nessuno lo infastidisca o lo offenda nelle sue convinzioni e nei suoi riti.»
La comunità dei pagani diviene sempre più debole: gli elleni più noti e influenti abbandonano Alessandria e Ipazia diventa il punto di riferimento per i pagani rimasti in città. Decide di sfidare Cirillo a un duello di idee in pubblico, come soluzione pacifica dello scontro, per trovare in qualche modo una mediazione tra cristiani e pagani. Durante il duello, Cirillo definisce Ipazia una prostituta e non si comporta in maniera leale, ma la lotta si conclude più o meno alla pari. Ipazia è come assente da quando uno dei cristiani, tra il pubblico, le ha chiesto se sa chi sia sua madre. A Ipazia è sempre stato detto che sua madre, una nobile dell’Illiria, è morta di parto, ma non è così: la sua vera madre è Demetra, la serva che le ha fatto da balia. Nei giorni che seguono, le due donne parlano a lungo. Presa dai suoi pensieri e dalla nuova vita che ha cominciato a vivere, Ipazia trascura il pericolo e un giorno, andando a lezione, viene ferita gravemente. Il medico riesce in qualche modo a salvarla, ma dopo il grande pericolo corso le ordina, per il bene della sua salute, di trasferirsi in campagna.
Qualcosa in lei è davvero cambiato: in Antinoo, servitore fedele, trova finalmente l’anima che la completa. Quando viene raggiunta dai suoi allievi, Ipazia decide di fare lezione in campagna: si forma così una comunità filosofica, una vera scuola, come aveva sempre desiderato.
Nel frattempo, Sinesio, divenuto vescovo di Tolemaide, ha perso tutto visto che i tre figli sono morti e Sinesio, sentendo di non aver molto da vivere, cerca di contattare Ipazia: muore tra le sue braccia, finalmente rappacificato con lei e con se stesso.
Ipazia torna dalla sua dimora di campagna, intenzionata a spendere la propria vita in nome della verità. Alessandria si presenta preda del furore delle opposte fazioni. Ipazia tenta di risolvere la situazione aiutando il prefetto Oreste, ma è ormai convinta da tempo che la filosofia è impotente contro l’irrazionalità della folla. Riprende il suo insegnamento al Museo, ma attorno a lei tutto parla di abbandono.
Dopo la decisione di Oreste di proibire una processione organizzata dal vescovo, Cirillo fomenta la reazione, dando la colpa a Ipazia, sicuramente l’ispiratrice delle scelte del prefetto. Aggredita mentre si reca al Museo, Ipazia viene uccisa sul sagrato del Cesareo, il tempio cristiano: Le gridano insulti e sconcezze, la toccano, le strappano le vesti, gridano, ridono risate oscene. Si spingono gli uni con gli altri, si calpestano, corrono come un branco di animali infuriati o sorpresi da un incendio. Non sono più una somma di uomini, ma un unico immenso animale acefalo che corre qua e là senza sapere dove né perché, reso cieco da un immenso furore. Sono come una muta di cani che abbia annusato l’odore della preda, ne abbia già assaggiato il sangue e non possa più fermarsi, non oda più il richiamo del padrone che vorrebbe trattenerla. Hanno bocche spalancate nell’urlo dell’odio, mani adunche che graffiano e sbranano, occhi sbarrati, senz’altra espressione che un’ira cieca e bestiale. La tirano da ogni parte, lacerandole la pelle e poi la carne; la prendono a calci sul ventre, sul petto, sul viso.
COMMENTO:
Libro molto coinvolgente e attuale: la storia di intolleranza che viene descritta potrebbe essere avvenuta ai giorni nostri. Ipazia è descritta a tinte vivaci: è un personaggio che suscita simpatia, una donna che vive per la verità e per la conoscenza, e che cerca di cambiare in qualche modo il corso della storia. Le sue intuizioni matematiche passano in secondo piano rispetto alla vicenda che la vede protagonista, ma è interessante vedere la lungimiranza con la quale ha proposto il sistema eliocentrico, andando contro il grande Tolomeo, e lo studio di mondi a più dimensioni.
Per il poco risalto che la sua vita ha avuto nel passato (difficilmente nominata quando si parlava dei matematici del passato), pareva che Cirillo avesse avuto ragione di lei, riuscendo a far dimenticare la sua esistenza: questo libro ce la descrive finalmente nella sua umanità e nella sua tensione verso la verità.
Questo libro è ora pubblicato con il titolo "Ipazia muore", l'autrice usa il suo vero nome, Maria Moneti Codignola, e la casa editrice è La Tartaruga Edizioni.
© 2020 Amolamatematica di Daniela Molinari - Concept & Design AVX Srl
Note Legali e Informativa sulla privacy